Che cosa sono e come funzionano le presse piegatrici? In che cosa si differenziano le presse piegatrici idrauliche, elettriche o ibride? Quali vantaggi comporta l’utilizzo di robot antropomorfi in celle di piegatura? Scopriamolo in questo articolo.

Le presse piegatrici, comunemente dette piegatrici, sono le macchine più diffuse e si stima che in Italia ce ne siano almeno 40’000. Queste macchine sfruttano il principio di piegatura a 3 punti in cui il pezzo da piegare appoggia sui due punti della matrice (cava fissa) e sullo spigolo del punzone (lama mobile).
Il pezzo usualmente è movimentato dall’operatore (oppure tramite un robot nelle celle di piegatura), ed è possibile eseguire solo pieghe verso l’alto; per eseguire pieghe verso il basso bisogna capovolgere il pezzo, il che non è sempre comodo, specialmente per lamiere di grandi dimensioni. Durante la piegatura, l’operatore deve “inseguire” la lamiera in modo da darne sostegno al peso del manufatto. Per tale ragione questo processo è molto legato alla manualità dell’operatore specializzato.
Il campo di lavoro di queste macchine va da larghezze di 800 mm a valori superiori e gli spessori lavorabili sono maggiori o uguali a 0.5 mm. Non esistono limiti di spessore e lunghezza su queste macchine. Le presse piegatrici possono essere: idrauliche, elettriche, ibride.
Presse piegatrici idrauliche
Quelle più diffusa sono le presse piegatrici idrauliche. Sono costituite da una traversa mobile, che viene azionata verticalmente (asse Y) da uno o due pistoni idraulici indipendenti tra loro, posti ai due lati della macchina utensile e comandati da valvole proporzionali. I cilindri sono rigidamente fissati alle due “spalle” che a loro volta sono connesse alla parte inferiore della macchina: il banco. Sul banco viene montata la matrice, mentre sulla traversa mobile si montano le lame di piegatura tramite degli attacchi rapidi chiamati “intermediari”. Delle fotocellule ottiche sorvegliano costantemente sulla sicurezza dell’operatore per evitare infortuni. Un controllo numerico gestisce il ciclo di lavoro e il movimento dei vari assi. Sulla parte posteriore della macchina, dei riscontri mobili fungono da battuta del pezzo per il corretto posizionamento dello stesso. I riscontri sono spesso motorizzati da viti a ricircolo di sfere e controllati da un CN avanti e indietro (asse X). Nelle macchine più moderne è possibile gestirli indipendentemente l’uno dall’altro (per esempio per pieghe coniche). Si può anche modificarne sia la quota in verticale (asse R) sia la posizione in orizzontale nel senso della larghezza della macchina (asse Z).
Presse piegatrici idrauliche sincronizzate
Da notare che al giorno d’oggi si parla di presse piegatrici sincronizzate in quanto i due pistoni sono sincronizzati nella discesa. In passato la funzione di sincronizzazione dei due pistoni era affidata a una barra di torsione. Questa tecnologia è oggi obsoleta. Ormai quando si parla di macchine idrauliche è sottinteso che siano sincronizzate.
In una pressa piegatrice, oltre alla tecnologia impiegata (olio, elettrica, ecc), bisogna fare attenzione anche al tonnellaggio e alla larghezza della zona di lavoro. Altri parametri importanti sono la corsa della traversa mobile, il tipo di intermediari e la profondità delle spalle.
Strategie per mitigare e compensare l’errore di centinatura
Gli errori più tipici delle presse piegatrici sono principalmente riconducibili alla deformabilità della struttura meccanica della macchina stessa. La traversa mobile essendo spinta sui due lati dai pistoni e dovendo piegare il pezzo sulla sua mezzeria tende a deformarsi secondo un errore di bombatura al suo centro, per questo è anche detto errore di centinatura. Poiché questo errore è difficile da eliminare, ci sono diverse strategie per mitigarlo e compensarlo, ma sono tutte basate sulla contro-centinatura della macchina per riportare il corretto parallelismo tra matrice e punzone su tutta la lunghezza della macchina:
- Centinatura automatica idraulica fatta con pistoni che piegano verso l’alto il banco, tipico dei costruttori italiani di piegatrici.
- Pre-centinatura (passiva) fatta manualmente o con motori di cunei, tipico dei costruttori nordeuropei.
- Centinatura attiva fatta con estensimetri (strain gauges) che misurano attivamente la deformazione della macchina durante la piegatura.
- Macchine “entry level” con sistemi passivi (indebolimenti sul banco).
Utensili di piegatura
Gli utensili usati nella piegatura si dividono in due macrocategorie:
- Utensili coassiali: tipici degli utensilieri americani, non richiedono intermediari; questi utensili hanno lo spigolo che è allineato con la zona di aggancio.
- Utensili non coassiali: tipici degli utensilieri europei, anche se la tendenza è di abbandonarli in favore dei coassiali. Questi utensili richiedono intermediari e tra lo spigolo e la zona di aggancio c’è una distanza a sbalzo.
Da notare che a volte gli utensili vengono venduti con lunghezze apparentemente inusuali, per esempio di 835 mm e di 415 mm. Questo fatto ha una ragione storica: una vecchia macchina di marchio Promecam era attrezzabile per una lunghezza totale di 1250 mm cioè 835+415 mm; per tale ragione le lame adottano tutt’oggi queste lunghezze standard. Esistono ovviamente anche gli spezzoni più corti chiamati “scarpette” di lunghezza standard, come 10, 15, 20, 40, 50, 100 e 200 mm.
Utensili non coassiali e intermediari
Nel caso si usino utensili non coassiali è opportuno usare gli intermediari, che sono delle attrezzature per il fissaggio rapido delle lame. Gli intermediari hanno caratteristiche uniformate:
- altezza 100
- larghezza 150
- tonnellaggio standard 100 ton/m.
Esistono anche intermediari più alti del normale per la lavorazione di scatolati molto alti, in modo da evitare collisioni tra il pezzo e la macchina. Gli intermediari possono avere:
- bloccaggio manuale tramite vite a brugola
- bloccaggio automatico ad aria compressa
- bloccaggio idraulico.
Analogamente, anche il bloccaggio della matrice sul banco può essere a vite, pneumatico oppure idraulico.
Tonnellaggio e lame
Il tonnellaggio degli intermediari è un fattore limitante per la piegatura. Durante la fase di piegatura di lamiere di grosso spessore bisogna fare attenzione al tonnellaggio della macchina, dell’utensile e della matrice, ma anche al tonnellaggio degli intermediari. Tutti e quattro i valori devono sempre rimanere sotto i limiti imposti dal costruttore, altrimenti si rischiano danni all’attrezzatura o alla macchina.
La macchina spesso è attrezzata con diversi set di lame a seconda delle diverse pieghe da eseguire in funzione della lunghezza, della tipologia di piega e del materiale da lavorare: questo perché non si può lavorare con la medesima lama sia l’acciaio inossidabile che il ferro zincato, altrimenti particelle di ferro zincato aderiranno alla lama, verranno trasferite alla lamiera inossidabile e fungeranno da innesco per la corrosione.
Presse piegatrici elettriche
Le presse piegatrici elettriche sono l’ultima frontiera delle macchine piegatrici. Il movimento della traversa viene azionato elettricamente attraverso diversi sistemi:
- viti a ricircolo di sfere
- cinghie in sostituzione dei cilindri idraulici.
Queste piegatrici garantiscono velocità (non bisogna scaldare l’olio) e ripetibilità, unite a bassi consumi elettrici (non c’è una centralina dell’olio sempre accesa e la corsa di ritorno può essere passiva tramite molle). Tuttavia, sono meno versatili e hanno costi molto più elevati rispetto alle piegatrici idrauliche. In aggiunta a questo, il tonnellaggio è inferiore rispetto a una macchina equivalente ma idraulica.
Le presse piegatrici elettriche possono arrivare fino a 4 metri di piegatura e a una forza di 300 tonnellate. Tuttavia, le piegatrici elettriche al giorno d’oggi sono ancora poco diffuse.
Presse piegatrici ibride
Le presse piegatrici ibride sono l’evoluzione delle piegatrici idrauliche a cui si uniscono i vantaggi delle piegatrici elettriche. Come le piegatrici elettriche, permettono rapidi movimenti e consumi ridotti. Il sistema si basa su un asse elettrico dotato di frizione idraulica e su un motore elettrico brushless, capace di fornire elevate forze e alte velocità di spostamento. Grazie a ciò, è possibile avere elevate spinte con ridotti consumi elettrici in quanto la macchina consuma energia solo durante la lavorazione.
Presse piegatrici robotizzate
La pressa piegatrice nel caso di grossi lotti può essere servita da un robot antropomorfo in una cella robotizzata. L’operatore si limita alla programmazione e all’eventuale attrezzaggio della piegatrice (se non eseguito automaticamente dal robot stesso). Il robot può essere antropomorfo e, in genere, corre su una slitta per tutta la lunghezza della piegatrice. Tale slitta può essere sia a terra che rialzata con il robot che lavora capovolto verso il basso su un binario.
Le lamiere grezze vengono caricate nell’area di prelievo. Sull’end effector del robot, infatti, c’è installata una pinza (tipicamente per pezzi piccoli), oppure un gruppo di ventose (tipicamente per pannelli e lamiere di maggiore dimensione). Durante il prelievo dei pezzi, questi devono avere un riferimento di posizione nello spazio ben definito: ciò viene ottenuto tramite un riscontro meccanico oppure tramite riconoscimento delle immagini acquisite da telecamere installate sul robot stesso.
Cella di carico
È molto importante che durante il prelievo della lamiera da lavorare non rimanga attaccato involontariamente anche il foglio successivo, cosa che succede quando si lavora materiale con protezione in PVC (per esempio con finitura satinata). Per tale ragione, i robot possono adottare sul polso anche una cella di carico con cui misurano la massa di quanto prelevato e la confrontano col peso nominale del pezzo. Nel caso in cui il robot rilevasse il prelievo di due o più pezzi, possono essere introdotte strategie di distacco più o meno efficaci, anche se, in generale, questo problema non ha una soluzione efficace al 100%.
Dopo il prelievo del pezzo, il robot si avvicina alla piegatrice e lo orienta come da part program redatto durante la programmazione a CAM da parte dell’operatore. La pressa piegatrice, quindi, esegue il ciclo di lavoro, mentre il robot accompagna la lamiera durante la fase di piegatura. Se necessario, il robot si riposiziona sfruttando dei supporti ausiliari per poter prendere il pezzo con orientamenti diversi.
Una volta che il ciclo di piegatura è finito, il particolare viene posizionato dal robot nell’area di scarico su dei pallet. A CAM è possibile definire delle strategie di impilamento in modo da ottimizzare la manipolazione dei pezzi.
Autore: Alberto Mora
Per la stesura di questo articolo sono state consultate le seguenti fonti:
R. Gastaldo, “Come scegliere la tecnologia migliore per piegare lamiere in azienda”, 2011
E. Corrieri, “La piegatura della lamiera”, Tecnologie Industriali, 2017
a cura di Maria Bonaria Mereu
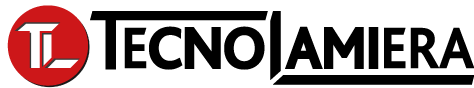
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere